Studio Cortelli
Articoli di approfondimento
Gestione di impresa
Costi fissi, costi variabili e punto di pareggio: dalla contabilità analitica all'analisi aziendale
Questo
articolo vuole offrire una breve panoramica sulla distinzione tra costi
fissi e costi variabili, in quanto è un aspetto molto importante che
ogni imprenditore dovrebbe sempre avere bene presente.
Sebbene
si tratti di un concetto che fa parte della contabilità industriale e
quindi pensato per le aziende che producono beni, in cui vi sono una serie
di costi specificatamente afferenti ad un prodotto, la sua progettazione,
l'organizzazione della produzione, l'utilizzo dei macchinari, la
pubblicizzazione, ecc., questa distinzione risulta estremamente
importante, in forma semplificata, anche per la aziende commerciali.
L'analisi
dei costi fissi e variabili può infatti effettuarsi, oltre che su un
singolo prodotto nell'ambito di una vera e propria contabilità
industriale, anche sull'azienda
nella sua interezza, o ad esempio per valutare la redditività
di filiali, stabilimenti e punti vendita.
Prima
di tutto occorre afferrare il concetto-base, pensato per un singolo
prodotto. Poi , in altro articolo, cercheremo di traslare questo concetto
anche sull'azienda
o su parte di essa.
Nell'ambito
della contabilità industriale, diventa fondamentale conoscere i fattori
che incidono sul costo di produzione di un
prodotto per poterne poi determinare il prezzo di vendita.
Supponiamo
ad esempio di volere produrre una scrivania, avremo un costo per la
progettazione ed il design, un costo per l'impostazione del lavoro, un
altro costo per l'utilizzo dei macchinari, quindi il costo del materiale,
il tempo dei dipendenti, infine la pubblicità per fare conoscere il
prodotto.
Alcuni
di questi costi sono fissi, ossia sono gli stessi
indipendentemente dal fatto che produciamo una sola scrivania o un milione
di scrivanie. Altri costi invece sono variabili, ossia sono
correlati al numero di pezzi prodotti. Il costo di progettazione sarà ad
esempio un costo fisso. Il costo dei materiali impiegati sarà invece un
costo variabile, ossia direttamente proporzionale al numero di pezzi
prodotti. Se produciamo una scrivania spenderemo ad esempio 100 Euro
di materiale, se ne produciamo 10 ne spenderemo 1.000, se ne produciamo
100 ne spenderemo 10.000, e così via.
Per
semplificare, immaginiamo che abbiamo un solo costo fisso, la
progettazione, ed un solo costo variabile, il materiale impiegato. Se ogni
scrivania ci costa 100 Euro di costi variabili (materiale), il prezzo di
vendita oltre i 100 Euro (importo che occorre per coprire i costi
variabili) serve per coprire i costi fissi (progettazione) e solo una
volta coperti tutti i costi fissi avremo finalmente un risultato
positivo.
Ipotizziamo
che i costi fissi ammontino a 2.000 Euro. Se vendiamo 40 scrivanie a 150
Euro l'una avremo 50 Euro (150-100 di costi variabili) da destinare in
primis alla copertura dei costi fissi. Tecnicamente questo importo prende
il nome di margine di contribuzione unitario.
Facciamo un semplice calcolo, 50 Euro * 40 scrivanie vendute fa 2.000
Euro, che servono esattamente a coprire i costi fissi. Si avrà quindi un pareggio.
Se invece avessimo venduto solo 30 scrivanie, sempre a 150 Euro, avremo
avuto (50*30=1.500) una perdita di 500 Euro, perché i ricavi di vendita
non avrebbero coperto l'insieme dei costi fissi + costi variabili. Se
invece avessimo venduto 50 scrivanie avremmo avuto (50*50=2.500) un utile
di 500 Euro, che residuavano dopo la copertura dei costi fissi + costi
variabili.
Il
punto di pareggio, in questo caso la vendita di 40 scrivanie per un totale
di 6.000 Euro, prende anche il nome di break even point, che
tecnicamente indica appunto il punto di pareggio, al di sotto del
quale si ha una perdita ed al di sopra del quale si ha un utile.
Per
spiegare meglio il concetto, ecco un semplice diagramma del punto di
pareggio. In questo caso è stato ipotizzato un articolo venduto a 10
Euro, con costi variabili di 6 Euro per ogni pezzo prodotto. I rimanenti 4
Euro, che costituiscono il margine di contribuzione unitario, devono
riuscire a copire i costi fissi, che sono stati ipotizzati in 10.000 Euro.
Ne consegue che occorrono 2.500 pezzi venduti per arrivare al punto di
pareggio (break even point). Sotto i 2.500 pezzi saremo in perdita, sopra
i 2.500 pezzi saremo in utile.
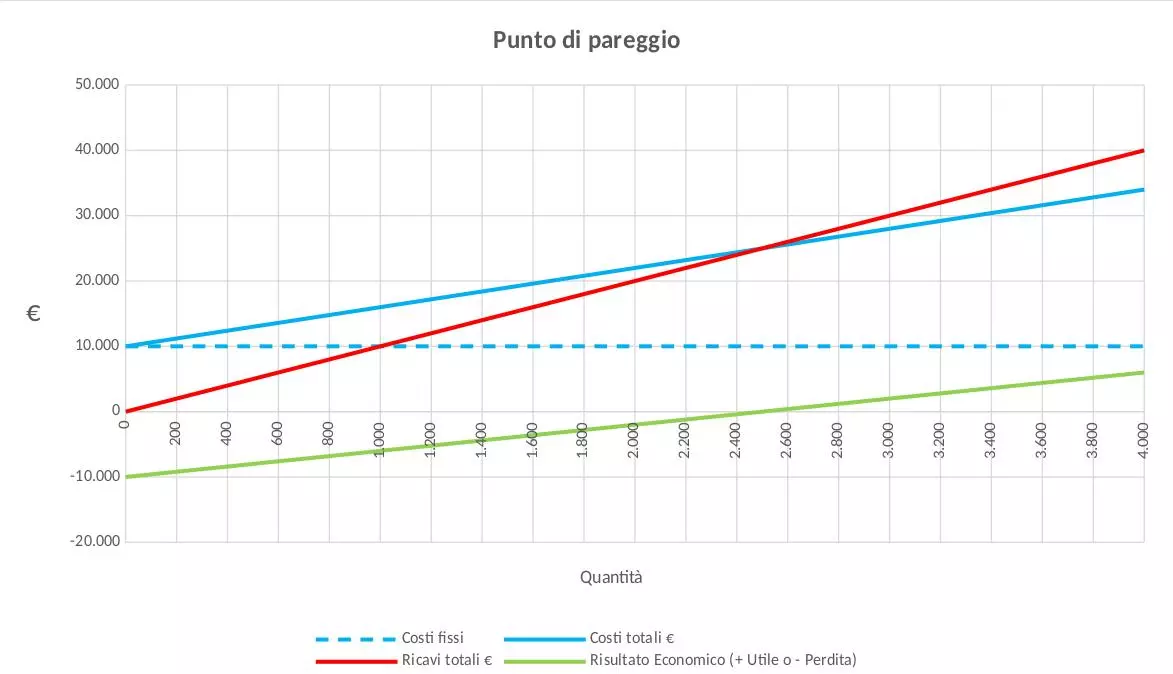
Il diagramma dimostra proprio questo, una diagonale che parte da zero,
quella rossa, con un'inclinazione maggiore che rappresenta i ricavi,
una diagonale che parte più in alto, quella azzurra, ossia dopo la
soglia dei costi fissi con un'inclinazione più moderata, che rappresenta i
costi (quelli fissi costituiti dall'altezza di partenza, quelli
variabili costituiti dall'inclinazione della diagonale). Laddove le
due diagonali si incrociano c'è il punto di pareggio e quindi, nello
spazio tra le due diagonali, avremo a sinistra l'area di perdita, a destra
l'area di utile (l'andamento del risultato da perdita a utile è
rappresentato dalla linea verde).
Come
accennato in apertura, questo calcolo non è tuttavia limitato alle sole
imprese industriali, ma può risultare molto utile anche nell'impostazione
della gestione di qualsiasi azienda, ne ho parlato più approfonditamente
in questo altro articolo.